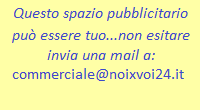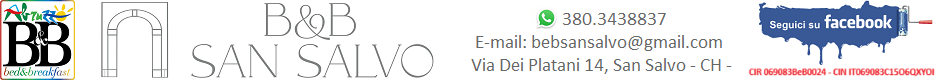Il Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto, costringe chiunque abbia del sangue che scorre nelle vene a fare i conti con un passato neanche troppo lontano e ad affrontare l’argomento. Si dice spesso “per non dimenticare”, espressione che rischia di scadere nella banalità e nella retorica, ma che esprime in pieno il senso che giornate come queste vogliono significare.
Ricordare e appropriarsi di cose non vissute sulla propria pelle è alquanto difficile, ma è a questo che servono le preziose testimonianze di chi invece ha visto e assistito, come quelle riportate nel libro di Gianni Orecchioni I sassi e le ombre. Storie di internamento e di confino nell’Italia fascista. Lanciano 1940-1943, dove vengono descritte le vicende di chi è stato all’interno dei campi di internamento dislocati in Abruzzo. Sì, perché è anche questo un punto centrale della questione: spesso si menzionano i grandi campi di concentramento come Auschwitz o Dachau, tralasciando o non sapendo che anche in ambito nazionale e regionale ne furono attivati molti.
Nel libro ci si sofferma sul campo di concentramento (e non di sterminio) di Lanciano, dove furono internate delle donne nel corso della seconda guerra mondiale e che venne liberato il 3 dicembre 1943.
Scrive Orecchioni: «Dopo poco più di due settimane dall’entrata in guerra dell’Italia, il 27 giugno 1940, con l’arrivo delle tre prime internate, iniziava l’attività del campo di concentramento femminile di Villa Sorge. La villa era situata a Lanciano, in provincia di Chieti, in contrada Viale Cappuccini ed era ubicata a circa un chilometro dalla città. Dal contratto di locazione allora stipulato risulta che essa era composta da 3 piani: «un piano terra con 4 camere, ingresso, gabinetto e un vano rustico; un primo piano con 5 camere, cucina, gabinetto con bagno e terrazzino coperto; un secondo piano con 3 vani». Il suo proprietario, l’Avv. Filippo Sorge, domiciliato a Pescara, l’aveva affittata alla Regia Prefettura di Chieti con un contratto annuale rinnovabile per la somma di £. 5.400 annue (pari a 450 lire mensili) a decorrere dal 3 giugno 1940, ossia già prima della dichiarazione di guerra di Mussolini. Come risulta dal contratto di locazione, la villa era ancora sprovvista degli impianti di gas e di luce elettrica ed era chiaramente specificato l’uso che il Ministero dell’Interno avrebbe fatto dell’immobile, che era quello dell’alloggiamento degli internati e dei confinati. [...] Il 15 settembre 1940 erano internate a Villa Sorge 49 donne più 4 bambini, ma nel complesso erano già passate nel campo 71 internate, 27 delle quali ebree. [...] Un altro nucleo consistente d’internate era costituito dalle «suddite nemiche» provenienti da vari Paesi, 14 delle quali erano inglesi».
Ma perché queste donne furono costrette al soggiorno forzato?
La risposta è scritta poco dopo nel testo: «La composizione così variegata delle internate era frutto del Regio decreto dell’8 luglio 1938, n. 1415, con cui si stabiliva che in Italia, appena iniziata la guerra, sarebbero stati internati gli stranieri di Stati nemici per motivi di sicurezza interna [...] onde evitare possibili forme di spionaggio e di collaborazione con gli oppositori interni, che pure venivano sottoposti ad analoga prigione preventiva».
Va detto che a questo decreto si aggiungevano le leggi razziali che privavano del diritto di soggiorno gli ebrei stranieri che per evitare le persecuzioni naziste avevano trovato rifugio in Italia.
Per ricostruire le dinamiche che si svolgevano all’interno del campo, lo studioso si è avvalso del libro di Maria Eisenstein L’internata numero 6, uscito nel 1944, dove viene narrato in prima persona il suo soggiorno coatto nel campo tra il 4 luglio e il 13 dicembre 1940.
Sono tanti gli aspetti che emergono dalle descrizioni di quella che era la “non vita” all’interno di Villa Sorge: «nel campo si era venuta a creare una microeconomia per cui ciascuno metteva a disposizione le proprie competenze per svolgere particolari funzioni remunerate: la cucina, le lezioni di lingua, il lavoro a maglia, la scrittura delle lettere», ma «quel che maggiormente irritava Maria era la degradazione umana del campo. Vivere malgrado tutto, accettare la vita come viene non è facile».
Viene comunque sottolineato che «attraverso le loro testimonianze e analizzando le relazioni dei medici provinciali sulle condizioni igienico-sanitarie dei campi, emerge che quello di Villa Sorge era uno dei più vivibili [...]», eccetto per il periodo che seguì il 12 febbraio 1942, cioè quando la villa divenne un campo di concentramento maschile per nazionalisti e comunisti slavi, dove la mancanza di acqua e medicinali la resero particolarmente degradata.
Nell’impossibilità di riassumere in poche righe vicende che meriterebbero ben più ampio spazio, si può solo dire che dalla lettura di punti di vista esterni e grazie a mirati approfondimenti storici si ha la sensazione che si vogliano “smascherare” colpe che una coscienza nazionale ha voluto spesso celare, «quasi che il popolo italiano fosse costituzionalmente immune dal compiere vere e proprie forme di persecuzione», nell’intenzione di far emergere e diffondere verità che talvolta si preferisce nascondere, ma che si ha il dovere di conoscere e ricordare.
F. P.